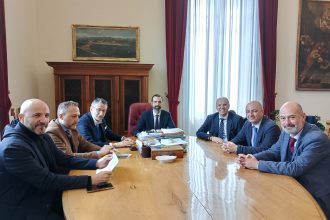In inglese si dice Great Resignation, in Italia si parla di dimissioni volontarie; fenomeno che sembra invertire la rotta del sistema capitalista entrato in crisi già nel 2020 con l’inizio della pandemia. Il Covid, infatti, non ha cambiato soltanto il nostro modo di interagire, ma anche di intendere il concetto di lavoro.
Di cifre e ricerche sul Great Resignation ne sono stati fatti diversi, noi ci siamo affidati ai dati del Censis, istituto di ricerca socio-economica italiano. Nel report, realizzato in collaborazione con Eudaimon e pubblicato a inizio marzo 2022, si dice che nei primi nove mesi del 2021 si sono registrate 1.362.000 di dimissioni volontarie: un incremento del 29,7% rispetto allo stesso periodo del 2020.
«Ma proprio nel 2020, – si legge nel rapporto – quando a causa del Covid il mercato del lavoro si era paralizzato, si era verificato un picco negativo di dimissioni: solo 1.050.000 nei primi tre trimestri, ovvero -18,0% rispetto al 2019. Si conferma però un trend di più lungo periodo di crescita delle dimissioni legato all’aumento della precarietà dei rapporti di lavoro».
Tuttavia, circa il 56,2% degli occupati non è propenso a lasciare il proprio lavoro, nella convinzione che non troverebbe un impiego migliore, più gratificante o semplicemente fare altro. «Fa più paura – scrive ancora il Censis – l’idea di ritrovarsi impantanati nella precarietà del mercato del lavoro». Questo però non vuol dire essere soddisfatti della propria occupazione.
Un lavoro come un altro
Parlare di Great Resignation, e quindi di lavoro e di occupazione è necessario: perché rappresenta una parte essenziale della vita dell’uomo, perché è grazie a questo che possiamo sostenerci, ma soprattutto perché possiamo sviluppare le nostre potenzialità. Ed è proprio questo il dilemma: trovare un lavoro che ci piaccia. Sempre i dati del Censis ci dicono che l’82,3% dei lavoratori (l’86,0% tra i giovani, l’88,8% tra gli operai) si dice insoddisfatto della propria occupazione e ritiene di meritare di più.
Questo malcontento è dovuto a diversi fattori:
- Retribuzioni: il 58,1% dei lavoratori ritiene di ricevere una retribuzione non adeguata al lavoro svolto. La percezione è confermata dalle statistiche ufficiali. Negli ultimi vent’anni le retribuzioni medie lorde annue nel nostro Paese si sono ridotte del 3,6% in termini reali (al netto dell’inflazione), mentre in Germania sono aumentate del 17,9% e in Francia del 17,5%. Pensando alla propria occupazione, il 68,8% dei lavoratori si sente meno sicuro rispetto a due anni fa (la percentuale sale al 72,0% tra gli operai e al 76,8% tra le donne). Nell’ultimo biennio il 66,7% dei lavoratori (il 71,8% tra i millennial) ha vissuto uno stress aggiuntivo per il lavoro e il 73,8% teme che in futuro dovrà fronteggiare nuove emergenze lavorative, con impatti rilevanti sulla propria vita quotidiana. Il lavoro, insomma, non paga abbastanza, non dà le certezze del passato, è fonte di tensione.
- Lo stress aggiuntivo sul lavoro: per il 51,3% degli occupati il proprio lavoro è molto cambiato durante la pandemia. Il digitale è stato determinante, ma non indolore. Infatti, complessivamente il 58,0% ha riscontrato difficoltà nell’utilizzo dei dispositivi digitali. In particolare, il 55,3% nella partecipazione ai meeting online e il 46,1% con la posta elettronica.
- Sullo smart working i lavoratori italiani si dividono: il 25,1% non vorrebbe farlo, il 32,9% è soddisfatto e vorrebbe proseguire, il 42,0% opterebbe per una soluzione ibrida.
- Il tempo di lavoro si dilata: il 39,7% degli occupati afferma di non disporre di tempo libero in modo sufficiente (e la percentuale sale al 45,1% tra gli esecutivi), il 23,0% prevede un ulteriore peggioramento nel futuro.
Quali alternative?
Di certo non possiamo azzerare tutto all’improvviso, ma è possibile agire partendo da strumenti già esistenti. Si parla quindi di rafforzare il welfare aziendale: il 91,2% dei lavoratori vorrebbe retribuzioni più alte, l’86,5% più servizi di welfare aziendale su ambiti come la sanità e l’assistenza per i figli, il 75,2% un maggiore supporto nel rispondere ai bisogni sociali quali la non autosufficienza di un familiare, la previdenza, l’istruzione dei figli. In sintesi: più soldi, più welfare aziendale, aiuto in situazioni di vita difficili.
A questo link il rapporto completo.
Il solarpunk
Da contrapporre, se così possiamo dire, al fenomeno del Great Resignation ci sarebbe il solarpunk. Già dal 2008 si parla di questo, «movimento culturale – come spiega Laura Carrer nella rivista siamomine – che interseca politica, estetica e stile di vita e si muove su una prospettiva di superamento del capitalismo e lotta alla crisi climatica. Al contrario degli illustri predecessori, rifiuta uno scenario distopico, riappropriandosi dell’ottimismo e della speranza verso il futuro, attraverso concetti di comunità, riuso e riciclo, post-work society, reddito di base, tecnottimismo, rispetto del regno vegetale.
Come ogni movimento artistico e letterario, offre delle visioni e delle idee, senza pretendere di fornire delle soluzioni, a maggior ragione senza prevedere un conflitto sociale che possa produrre un reale cambiamento. Tuttavia è interessante analizzarne i contorni per capire quali spunti può offrire all’immediato presente, per immaginare una società più sostenibile e lontana dalle logiche spietate di greenwashing» (ecologismo di facciata, che indica la strategia di comunicazione di certe imprese, organizzazioni o istituzioni politiche finalizzata a costruire un’immagine di sé ingannevolmente positiva, ndr.). Insomma, un nuovo sguardo sul futuro, perché se lo stiamo pensando, lo possiamo anche realizzare.
(In foto Charlie Chaplin in “Tempi moderni”, 1936)
(249)